Mozione - Indirizzo PAESC *RESPINTA*
- Fusignano per la Sinistra

- 27 set 2021
- Tempo di lettura: 12 min
Premesso che:
Con delibera n. 20 del 27/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato, tra le altre cose, la proroga per l’approvazione del PAESC al 31/10/2021.
In data 14/07/2021 la Commissione Europea ha mandato la comunicazione Fit for 55 al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni, con cui ha confermato la riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030.
In data 11/12/2019 la Commissione Europea, attraverso l’European Green Deal, ha affermato che avrebbe rivisto, entro l’estate 2020, l’obiettivo della riduzione dei gas climalteranti nell’UE portandolo al 55% rispetto alle emissioni del 1990; decisione riconfermata durante una conferenza stampa tenutasi il 14/07/2021 con alle spalle l’entrata in vigore dell’European Climate Law il 04/03/2020.
La Commissione Europea, attraverso l’European Green Deal pubblicato in data 11/12/2019, ha indicato che la produzione e l’uso di energia lungo i settori economici provocano più del 75% delle emissioni di gas climalteranti nell’Unione Europea, comportando che l’efficienza energetica degli edifici è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 fissati.
I crediti di carbonio sono un sistema che consente alle aziende e alle istituzioni di compensare le emissioni di CO2, promuovendo progetti zero carbon in tutto il mondo, con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality.
Il suolo è una risorsa non rinnovabile, a causa dei lunghi tempi di formazione, nonché un ecosistema essenziale, complesso, multifunzionale e di vitale importanza sotto il profilo ambientale e socioeconomico che svolge diverse funzioni ecologiche e fornisce diversi servizi ecosistemici all’essere umano. La Commissione Europea nel 2012 ha definito un ordine di priorità per raggiungere l’azzeramento del suo consumo entro il 2050 (evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali; mitigare e ridurre gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo; solo se gli interventi dovessero risultare inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie di qualità e funzione ecologica equivalente), così da impedire e riassorbire il fenomeno del degrado del suolo.
Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure gli edifici residenziali.
Nella Missione 2 Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” Ambito 2 “Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati destinati 13,81 mld per “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”.
Attraverso l’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe, convertito nella legge n. 8/2020 il 29 febbraio 2020, si sono regolamentate le forme di autoconsumo energetico, come le comunità energetiche, in cui i membri della comunità si uniscono volontariamente con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti energetici locali, diventando così dei prosumer.
Nella Missione 2 Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito 1 “Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile” e Ambito 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” del PNRR sono stati destinati 2,20 mld per la “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” e 3,61 mld per il “Rafforzamento smart grid”.
Nella missione 2 Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito 3 “Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno” sono stati destinati un totale di 3,19 mld.
In base al rapporto di monitoraggio del Luglio 2021 “Fonti rinnovabili in Italia e nelle regioni” del GSE (https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20statistico%20di%20monitoraggio%20di%20cui%20al%20DM%2011-5-15%20art%207_anni%202012-2019.pdf), la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da FER al 2019 era pari al 18,2%, di cui il 9% riguarda il settore dei trasporti. L’Emilia-Romagna però copre i propri consumi energetici con fonti rinnovabili solo per l’11,3%, risultando una delle regioni con il peggior dato dopo Liguria e Lazio seppure sia riuscita a superare la previsione prevista nel decreto Burden Sharing.
Il settore dei trasporti è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2 in UE ed è anche l’unico settore che dal 1990 a oggi ha avuto un aumento delle emissioni climalteranti (Fonte: Agenzia europea dell’ambiente - https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190322PHT32342/20190322PHT32342_original.jpg). Le principali responsabili delle emissioni sono le autovetture, che generano il 60,7% delle emissioni di CO2 relative ai trasporti, anche a causa della media di passeggeri per auto, pari a 1,7.
Nella Missione 2 Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito 1 “Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile” del PNRR è previsto un investimento pari a 1,10 mld per lo sviluppo dell’agrovoltaico.
Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, l’agricoltura contribuiva alle emissioni di gas serra per il 10% al 2012 nell’UE, le quali sono dovute al rilascio di metano e di protossido di azoto (Fonte: EEA - https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2015/articoli/agricoltura-e-cambiamento-climatico).
L’allevamento contribuisce, attraverso il rilascio di metano per la produzione casearia e della carne, soprattutto bovina, a causa della fermentazione enterica del processo digestivo animale e della produzione dei mangimi – che tolgono anche terreno per la produzione agricola con destinazione umana –, al cambiamento climatico con 3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente (Fonte: EEA - https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2015/articoli/agricoltura-e-cambiamento-climatico).
Nel 2017 è stata lanciata l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici”, che vuole vietare l’utilizzo del comune pesticida, utilizzato anche nella produzione di cibo a destinazione umana, etichettato dall’OMS come “probabilmente cancerogeno”, non dimenticando anche la sua pericolosità per la vita delle piante e degli animali.
Nel 2018 è stata lanciata l’ICE “Stop the cage age”, che vuole eliminare l’utilizzo di gabbie nell’allevamento di ogni animale.
Il progetto sul Canale dei Molini elaborato dall’Amministrazione Provinciale di Ravenna prevede l’utilizzo del Canale come strumento di collegamento delle aree di interesse naturalistico lungo il suo percorso e nelle sue vicinanze, che comprenderà anche aree e itinerari del Comune di Fusignano.
Considerato che:
La compravendita dei crediti di carbonio permette alle aziende e alle istituzioni la pratica del green washing, attraverso cui dimostrano meno emissioni di CO2 rispetto a quelle realmente prodotte, complicando la comunicazione verso la cittadinanza e creando confusione sulle reali politiche ambientali, e sui loro effetti, intraprese dagli enti pubblici e dalle aziende.
SNPA utilizza un sistema di classificazione per il consumo di suolo suddiviso in due categorie principali, permanente e reversibile, e, dove possibile, in una terza categoria per le altre forme di copertura non incluse nel consumo di suolo.
I costi annuali medi dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici si può stimare, se fosse confermata la velocità media 2012-2020 anche nei prossimi 10 anni, a un valore complessivo compreso tra 81,5 e 99,5 miliardi di euro (Fonte: SNPA - https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2021-1.pdf).
Secondo le stime di SNPA, si potrebbe limitare la conversione di terreni agricoli in campi fotovoltaici attraverso un pieno sfruttamento degli edifici e fabbricati disponibili, che permetterebbero un incremento tra i 59 e i 77 GW sufficiente a coprire l’aumento di energia rinnovabile previsto dal PNIEC al 2030 (https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2021-1.pdf).
L’Emilia-Romagna registra un valore percentuale di suolo consumato sopra la media nazionale compreso tra il 7% e il 9%, un tasso di variazione del consumo di suolo maggiore del tasso di variazione della popolazione, una lenta trasformazione delle aree rurali ad aree suburbane e urbane. La provincia di Ravenna registra i peggiori valori in Emilia-Romagna sul consumo di suolo nel 2019-2020 con valori in ettari pari a 90 e in rapporto alla popolazione pari 2,33 m2/ab/anno e il valore di suolo consumato al 2020 risulta pari al 10,10% (https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2021-1.pdf).
Il problema della povertà energetica, cioè l’impossibilità a far fronte alle spese per le bollette dei servizi energetici, che in Italia comprende il 14,1% delle famiglie per quanto riguarda il mantenere adeguatamente calda la casa, contro una media del 7,3% in UE (Fonte: EU Energy Poverty Observatory - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b9a25ba4-9ef6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en).
Secondo i dati ISTAT (https://www.istat.it/it/files//2021/07/Incidenti-stradali_2020.pdf), le auto sono il mezzo più pericoloso con 97.346 feriti e 1330 morti nel 2020, mentre le biciclette e i monopattini elettrici registrano rispettivamente 13.329 feriti e 169 morti e 518 feriti e 1 morto. Nonostante ciò, bisogna tenere conto della dinamica degli incidenti, che potrebbero sottolineare un’ulteriore pericolosità dell’auto. Non a caso, l’ISTAT indica anche che “gli indici di mortalità e lesività per categoria di utente della strada evidenziano rischi più elevati per gli utenti vulnerabili, rispetto a quelli di altre modalità di trasporto. L’indice di mortalità per i pedoni, pari a 3,2 ogni 100 incidenti per investimento di pedone, è oltre quattro volte superiore a quello degli occupanti di autovetture (0,7). […] per i ciclisti è, invece, quasi doppio (1,2).
Nonostante l’auto elettrica sia meno green per quanto riguarda lo smaltimento e la produzione, tenendo conto del mix energetico medio in Europa, sono considerabili più ecosostenibili rispetto ai veicoli alimentati con combustibili fossili (Fonte: Parlamento Europeo - https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190313STO31218/emissioni-di-co2-delle-auto-i-numeri-e-i-dati-infografica).
Il silvicoltore urbano Cecil Konijnendijk van den Bosch, in un articolo pubblicato su Linkedin il 19/02/2021 e ripubblicato da Urban Alliance il 22/02/2021, ha proposto la regola 3-30-300, per cui la pianificazione urbanistica dovrebbe tenere conto che ogni famiglia dovrebbe vedere almeno 3 alberi dalla propria casa, che ogni quartiere dovrebbe avere una copertura di foresta urbana pari ad almeno il 30% e che ogni persona dovrebbe avere a un massimo di 300 metri il più vicino spazio verde.
La copertura tramite foresta urbana permette di ridurre le temperature delle città, di ridurre il consumo di energia elettrica per l’aria condizionata, di aumentare la qualità dell’aria, di ridurre l’inquinamento e i gas climalteranti, di aumentare la qualità dell’acqua, di ridurre il deterioramento delle strade e dei marciapiedi (con conseguenze sui costi di manutenzione), di aumentare la biodiversità e di ridurre l’inquinamento acustico (Fonte: EPA - https://www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands).
La Sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha lanciato la proposta della città dei 15 minuti, dove scuole, posti di lavoro, negozi, supermercati, parchi pubblici, palestre e impianti sportivi sono a un massimo di 15 minuti di distanza e l’uso dell’auto è ridotto.
L’agrovoltaico permette di creare sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettono l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, limitando così il consumo di suolo, e permette di aumentare la produttività del terreno sia in termini economici, poiché permette alle aziende di avere entrate anche dall’impianto oltre che dalla produzione agricola, sia in termini agricoli, poiché permette di ridurre il fabbisogno idrico delle colture.
In linea con l’aumento della popolazione e con il mutamento delle abitudini alimentari a favore di un maggiore consumo di carne, la domanda globale di cibo potrebbe aumentare anche del 70%, con un forte impatto sul clima a causa del conseguente aumento delle emissioni climalteranti (Fonte: EEA - https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2015/articoli/agricoltura-e-cambiamento-climatico).
La principale causa di emissioni climalteranti in agricoltura, soprattutto nell’agricoltura intensiva, è l’utilizzo di fertilizzanti composti da fosfati e nitrati, che possono anche causare l’eutrofizzazione delle acque, fenomeno che favorisce la crescita delle alghe e riduce la quantità di ossigeno nell’acqua influenzando pesantemente la vita acquatica e la qualità idrica.
Un uso scorretto dell’irrigazione agricola, anche a causa dell’uso di tecnologie obsolete e non inseribili in un contesto di agricoltura 4.0, compromette la fertilità dei terreni e contribuisce alla loro desertificazione.
In Italia, il 68% degli animali, pari a 43.854.804 animali, viene allevato in gabbia e la legislazione interviene solo per gli allevamenti di anatre e oche (https://www.endthecageage.eu/uneuropa-100-libera-dalle-gabbie/).
Tenuto conto che:
In Italia, come in Europa, pesa l’assenza di una Direttiva quadro sul suolo con lo scopo di proteggere il suolo dall’uso indiscriminato e dalla sua progressiva artificializzazione che permetta di raggiungere gli obiettivi di: azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050; protezione adeguata del suolo anche con l’adozione di obiettivi relativi al suolo in quanto risorsa essenziale del capitale naturale entro il 2020; allineamento di consumo alla crescita demografica reale entro il 2030; bilancio non negativo del degrado del territorio entro il 2030.
SNPA indica che praticamente dovunque non c’è coerenza nelle direttive rispetto a quelle europee e nazionali riguardo al consumo di suolo, con deroghe o eccezioni significative relative a tipologie di interventi di trasformazione del territorio che non vengono inclusi nel computo ma che sono in realtà causa di consumo di suolo.
Il passaggio alle forme di autoconsumo permette di ridurre la dipendenza da qualsiasi combustibile fossile, permettendo di conseguenza di ridurre le trivellazioni e le importazioni dei combustibili fossili, una riduzione dei costi e una responsabilizzazione energetica degli utenti, di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 e di completare la transizione a sistemi energetici completamente rinnovabili.
In base alle dichiarazioni del ricercatore Leonardo Setti dell’Università di Bologna, l’idrogeno, di qualsiasi tipo (grigio, blu, verde), non è sostenibile a causa delle emissioni di CO2 o CO2 equivalenti (grigio e blu) e del consumo di suolo e del consumo di acqua richiesti dalla sua produzione; quindi, la sua adozione strategica dovrebbe essere limitata a quei settori di trasporto e di produzione industriale (industria pesante e trasporti navali e aerei) in cui non esistono ancora tecnologie alternative adeguate.
Sul sito di ARPAE non risultano esserci report riguardo alla situazione locale sul consumo di suolo.
Le proposte urbanistiche della Hidalgo e di Konijnendijk devono essere adattate per prevederne l’adozione sul Comune di Fusignano.
Lo studio effettuato dall’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente ha sottolineato che il costo per albero della foresta urbana si aggiri tra i 15 e i 65 dollari all’anno mentre il guadagno netto tra i 30 e i 90 dollari all’anno (https://www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands).
Per le fasce più basse della popolazione è economicamente più accessibile il cibo spazzatura rispetto a un cibo più salutare come quelli vegetali, con conseguenze sia sulla loro salute (quindi sui costi della sanità) sia sull’ambiente.
Gli allevamenti intensivi sono un probabile strumento per la nascita di nuove epidemie e pandemie dovute a un salto di specie, come avvenuto per l’aviaria e il coronavirus, e comportano l’antibiotico resistenza secondo l’OMS e la FAO, considerando che il 70% degli antibiotici venduti in Italia sono destinati agli allevamenti in base ai dati EFSA (https://www.ciwf.it/area-stampa/comunicati-stampa/2020/03/epidemie-e-allevamenti-intensivi-5-fatti-da-sapere?fbclid=IwAR0M0jqOxxB_-f_I0ZR96cnEmu0rhghmX2pCBNMc_2nOsgY3KMySFRjqTrc).
La Commissione Europea si è impegnata a introdurre una legge per eliminare le gabbie negli allevamenti entro il 2027.
Visto che:
Il 17/12/2019 questo Consiglio ha approvato a maggioranza una mozione in relazione all’emergenza climatica, in cui era presente l’impegno di istituire la zona 30 nel centro storico; decisione riconfermata dalla mozione “Agenda per una mobilità sostenibile per Fusignano” approvata in data 30/06/2020.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A
Rivedere al rialzo l’obiettivo della riduzione dei livelli di CO2 da raggiungere entro il 2030, passando dal 40% al 55%, allineandosi così agli obiettivi europei.
Pubblicare il valore delle compravendite relative ai crediti di carbonio, se detenuti, del Comune di Fusignano e degli enti partecipati dal Comune, indicando anche gli enti o le aziende da cui e a cui i crediti di carbonio sono stati acquistati e venduti.
Inserire nel nuovo PAESC del Comune di Fusignano e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna le seguenti missioni:
M1. Consumo di suolo
Verificare l’attuale normativa comunale sul consumo di suolo ed eventualmente allinearla alle direttive europee e nazionali.
Prevedere il monitoraggio, la raccolta dati e la pubblicazione di report a livello locale in collaborazione con ARPAE con una cadenza almeno biennale.
Controllare periodicamente le direttive europee e nazionali in corso di adozione e quelle di futura adozione e aggiornare le normative locali in base alle decisioni delle stesse direttive.
Prevedere eventualmente il miglioramento e il superamento delle direttive europee e nazionali in base alle indicazioni date dagli istituti di monitoraggio come SNPA, ISPRA e ARPAE.
Limitare il consumo di suolo a quegli interventi inevitabili ed evitare nuove urbanizzazioni e impermeabilizzazioni delle aree rurali.
Introdurre una norma locale sulla compensazione del consumo del suolo che preveda che ad ogni progetto che provoca una nuova copertura di suolo si progetti in parallelo la rinaturalizzazione di un’area di superficie pari o superiore a quella del suolo coperto.
M2. Energia
Favorire la nascita delle comunità energetiche a Fusignano e nelle frazioni (San Savino, Maiano, Rossetta, Scambio), aiutando i cittadini nell’orientamento tecnico e legale e nel loro incontro e messa in comune dell’energia.
Completare l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e l’efficientamento energetico degli stessi.
Permettere agli impianti fotovoltaici degli enti pubblici di essere un centro di produzione delle comunità energetiche comunali.
Prevedere incontri e servizi di supporto per massimizzare la conoscenza del Superbonus 110%, così da permettere a chiunque ne abbia la possibilità e più bisogno di ottenere i fondi per l’efficientamento energetico delle proprie proprietà.
Pensare misure che favoriscano il contrasto alla povertà energetica nel mentre che si completa la transizione alle comunità energetiche.
Progettare l’introduzione della smart grid nel Comune di Fusignano e nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Supportare i cittadini, attraverso una comunicazione chiara, efficace e puntuale e incontri dedicati, nell’ottenere la conoscenza degli strumenti a disposizione per orientarsi nella scelta dei fornitori dell’energia, degli incentivi (anche regionali e nazionali) attualmente disponibili e delle modalità attraverso cui richiederli e del sistema di classificazione alla base dell’etichetta energetica dell’UE.
Monitorare e pubblicare i dati relativi all’efficienza energetica degli edifici pubblici e, in generale, del territorio comunale.
Legiferare una limitazione dell’adozione e degli investimenti sull’idrogeno, soprattutto relativamente alla mobilità su gomma tramite automobili.
M3. Urbanizzazione
Pensare a un modello di urbanizzazione che tenga conto della regola 3-30-300 e riadatti il modello della città dei 15 minuti su Fusignano.
Sviluppare un verde urbano diffuso e la silvicoltura anche nel centro storico di Fusignano.
Introdurre la zona 30 nel centro storico.
Sfavorire la mobilità su gomma, soprattutto con combustibile fossile, e sviluppare percorsi urbani per la mobilità dolce e pedonale.
Installare, in punti strategici, punti di ricarica per le auto elettriche, con l’obiettivo di avere almeno un punto di ricarica per ogni area di parcheggio comunale.
Inserire delle rastrelliere nel centro storico e dei punti per il bike e il monopattino elettrico sharing.
Potenziare il progetto e gli itinerari naturalistici del Canale dei Molini.
M4. Agricoltura e allevamento
Favorire l’incontro tra aziende e fondi del PNRR per sviluppare l’agrovoltaico.
Rafforzare e prevedere nuove iniziative in favore dei prodotti agricoli a Km0.
Sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto di una dieta basata sul consumo di carne e di prodotti derivati dagli animali, facendo conoscere di conseguenza la presenza di prodotti e diete alternative (vegetarianismo, veganismo, pescetarianismo o flexitarianismo) ed eliminandone gli stereotipi e pregiudizi.
Costruire iniziative che coinvolgano gli agricoltori e le attività, di vendita e ristorazione, locali per contribuire alla conoscenza delle diverse diete disponibili e della qualità di queste alternative.
Prevedere misure che aiutino le fasce più deboli ad avere un maggiore accesso a cibi salutari e vegetali, anche sensibilizzando sull’impatto sulla salute e sull’ambiente del cibo spazzatura.
Aumentare i controlli relativi all’utilizzo di fertilizzanti e il rispetto delle norme in ambito agricolo.
Cooperare con i sindacati e le associazioni di categoria per introdurre nuove limitazioni sull’utilizzo di fertilizzanti a base di fosfati e nitrati, nonché di altri fertilizzanti e prodotti destinati all’uso agricolo dannosi per l’ambiente, l’umano e la biodiversità animale e vegetale.
Supportare le aziende agricole a convertire la loro produzione agricola a un’agricoltura 4.0 o comunque a un’agricoltura che faccia un uso consapevole e adeguato di tecnologie che permettono di ridurre l’impatto ambientale e di aumentare la produttività agricola.
Vietare l’utilizzo del glifosato entro il 2023 nel Comune di Fusignano.
Introdurre una norma per l’eliminazione delle gabbie negli allevamenti sul territorio del Comune di Fusignano entro il 2027 e tenere sotto controllo le normative e le direttive promulgate in Unione Europea per allinearsi ad esse.
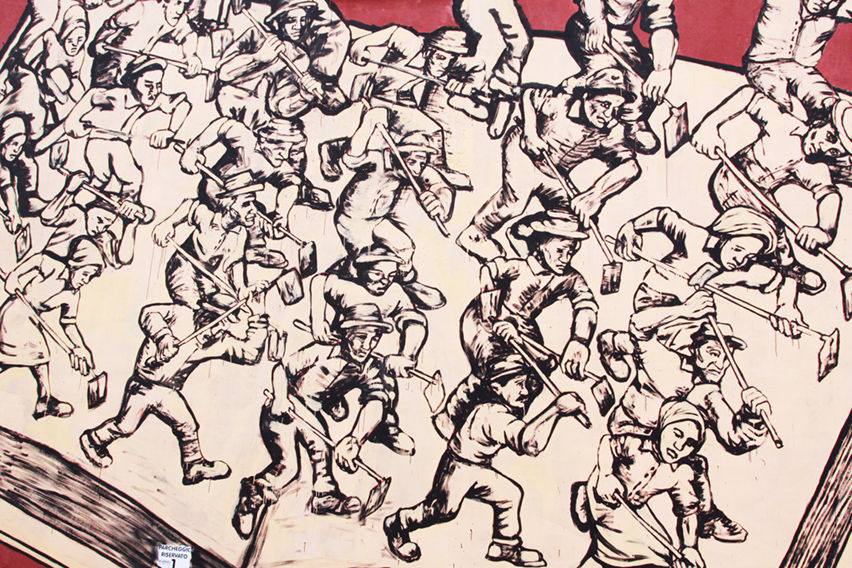

Commenti